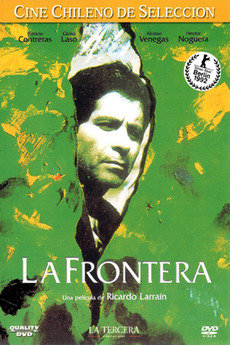Raccontare i soprusi di una dittatura lo si può fare in vari modi. E’ possibile naturalmente intessere una storia collocata storicamente nel periodo in cui si manifesta il fenomeno (molti film sono ambientati nell’era Pinochet). Si può parlarne indirettamente in un paese imprecisato, attraverso la riemersione di un passato traumatico (vedi Polański in La morte e la fanciulla). C’è anche la possibilità di fare come Ricardo Larraín nel suo capolavoro La frontera, in cui l’epoca Pinochet traspare in controluce nel luogo dell’esilio destinato a chi non ha accettato le regole di una dittatura.
Il film, vincitore dell’orso d’argento al festival di Berlino del ‘92, è stato girato nel 1991, quando il regime militare, dopo le elezioni presidenziali del 1989, era stato sostituito dalla presidenza di Patricio Aylwin, contraddistinta dal tentativo di ridurre il potere dei militari e di far luce sulle violazioni dei diritti umani.
La vicenda invece si svolge in pieno epoca Pinochet e vede Ramiro Orellana (interpretato da Patricio Contraras), un professore di matematica, condannato all’esilio interno (la cosiddetta relegación) per aver firmato una protesta pubblica sul rapimento e la scomparsa di un suo collega. La destinazione è un’isola lungo la costa meridionale del Cile, al largo della Patagonia, caratterizzata da vento pungente, piogge alluvionali e pozze d’acqua grandi come laghi. La luce e il paesaggio antartico sono evidenziati da una preziosa fotografia, che ricorda in particolare le immagini oniriche create dal genio Andrej Tarkovskij.
Il suo status di esiliato all’inizio del film (fin dall’accompagnamento in macchina dei due agenti della polizia politica, con la loro stupidità burocratica di rappresentanti del governo centrale) è da lui orgogliosamente distinto dall’etichetta di terrorista; in realtà non lo preserva dal suo destino: vivere lo stesso isolamento e l’assurdo sradicamento dalla quotidianità vissuto dai militanti torturati. Il merito del cineasta cileno Ricardo Larraín è proprio quello di narrare per la prima volta le sofferenze degli scomparsi e dei “morti viventi”, di quella parte della popolazione che non si è mai più ripresa, ritirandosi in un’alienazione totale. Ramiro Orellana si trova in un mondo isolato abitato da un numero di persone che, per scelta o per obbligo, hanno rinunciato alle comodità del mondo moderno.
Come Cristo si è fermato a Eboli di Rosi, in La frontera è centrale lo scontro tra la tradizione e le ancestrali forme di vita primitiva (incarnata dalla figura della guaritrice che usa la medicina Mapuche) e la minaccia del progresso senza anima. Questo contrasto acquista maggiore spessore se lo si inquadra in una “condizione” di esilio, inteso come lotta per la salvezza dall’oppressione e dalla mancanza di libertà. Il confine è mirabilmente raffigurato dal cineasta cileno nel corso d’acqua che divide l’universo arcaico e primitivo dal moderno, solcato da una zattera che porta solo disturbo, come ad esempio nel caso della visita della ex moglie e il figlio di Ramiro. Il confine è il simbolo della cultura cinematografica cilena, ma anche della transizione politica che accomuna il Cile alla Spagna franchista degli anni ’70.
Non a caso Ricardo Larraín è un regista cileno di origine basca. E si avvale della collaborazione dello sceneggiatore argentino Jorge Goldemberg, per puntare ancora di più la rotta verso la lotta dell’uomo per la difesa della dignità e dei diritti fondamentali di libertà.
Ispirato al realismo magico di Gabriel García Márquez, il mondo rurale del confine si adatta con il passare del tempo alla quotidianità del professore di matematica Ramiro Orellana: inizia ad amare, dopo un iniziale rifiuto, la semplicità della vita di campagna e i suoi abitanti.
Prima Ramiro deve solo firmare il registro di presenza di fronte al delegato del governo. Poi soggiorna e lavora come assistente ad un parroco anglosassone (interpretato da Héctor Noguera) che cerca invano di introdurre dottrine cristiane in un contesto ateo e agnostico. Dopo il fallimento del suo primo matrimonio in patria, conosce ed ama la bella Maite (la brava Gloria Laso), una donna di origine spagnola che emigrò in Cile in fuga dalla dittatura franchista attraverso la mediazione di Pablo Neruda, e che vive in una casa dirupata con un padre anarchico, rimasto con la mente al passato e pieno di odio per la sua terra natale. Inoltre “lavora” come assistente ad un subacqueo “loco”, che in maniera poetica vuole trovare le cause delle tanto temute onde di marea e scoprire vecchi oggetti sul fondo del mare.
Giungerà finalmente l’annullamento della condanna per il professore di matematica, ma insieme ci sarà un maremoto che distruggerà il paese e causerà la morte di Maite. La fine è dunque altamente metaforica e la regia va di pari passo. Larraín abilmente unisce una scena di sesso della coppia, una preghiera di guarigione e una panoramica in movimento su un cielo tempestoso: è come se questo assemblaggio faccia esplodere al rallenty lo tsunami e la morte dell’anarchico spagnolo. La musica che accompagna questa sequenza è vicina ai film horror, fantastici o religiosi.
La “favola” termina simbolicamente con il crollo della dittatura che fa sentire la sua eco proprio in una frontiera che ha preservato il desiderio di democrazia e il ricordo della memoria, che invece sono stati soffocati dal mondo ufficiale. L’esiliato Ramiro si è dunque svegliato ed ha meglio compreso quello che gli è accaduto. Ad un giornalista televisivo che gli chiede cosa sia successo, non può che ripetere la sua identità e la colpa per cui ha subito la relegación. Ora potrà portare la sua esperienza di frontiera anche nel mondo civile e politico, immettendo quei valori naturali e primitivi che ha imparato. Questo sarà il suo contributo nella battaglia tra upelientos e momios che si appresterà a vivere tornando nel Cile ufficiale, al di là del mondo a parte che ha vissuto.